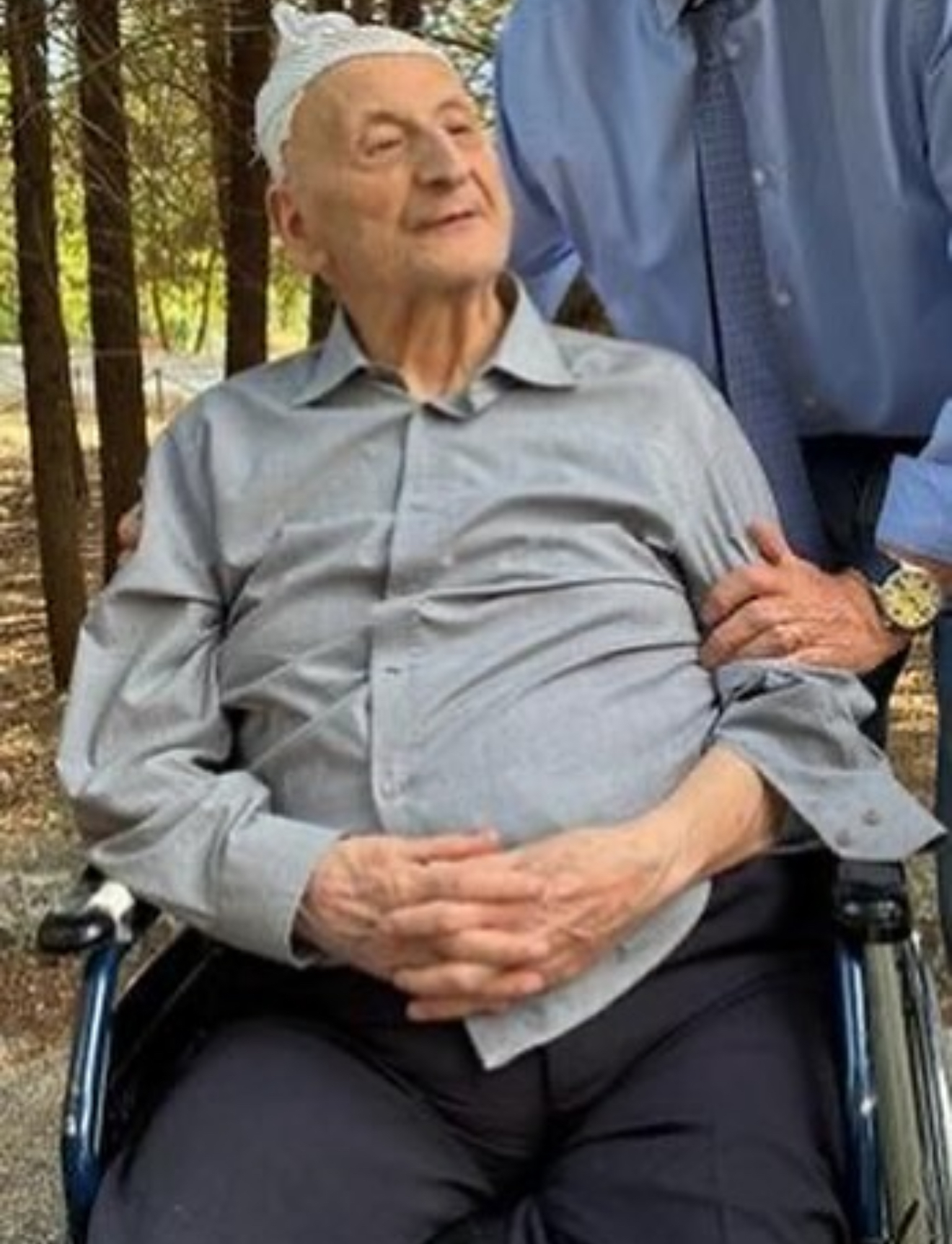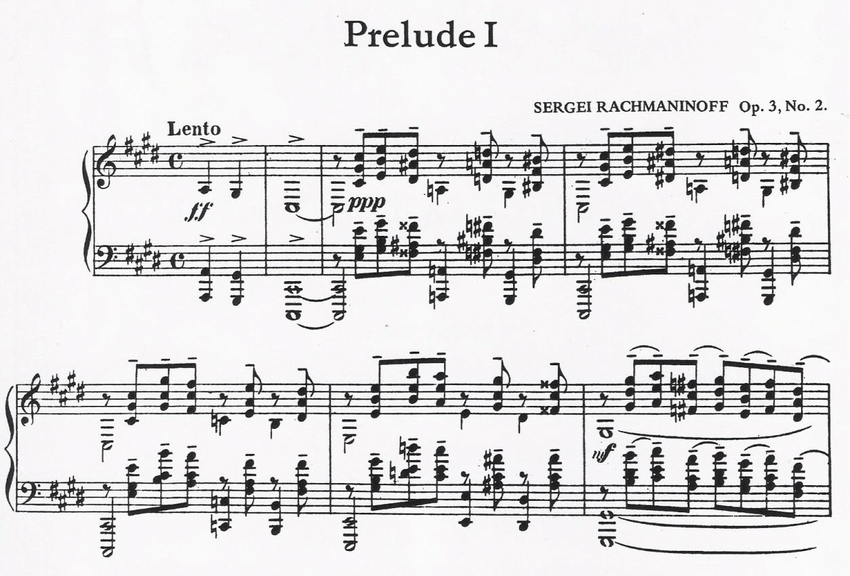Cosa significa essere uomini? Come esserlo? Una strada vale l’altra? Una scelta vale l’altra? La cronaca registra sovente un modo di essere uomini che radica in quella convinzione secondo la quale, per essere tali, bisogna farsi valere, è necessario mostrare di cosa si è capaci. Questo significa essere uomini? Quando non si riesce più a …
 Cosa significa essere uomini? Come esserlo? Una strada vale l’altra? Una scelta vale l’altra?
Cosa significa essere uomini? Come esserlo? Una strada vale l’altra? Una scelta vale l’altra?
La cronaca registra sovente un modo di essere uomini che radica in quella convinzione secondo la quale, per essere tali, bisogna farsi valere, è necessario mostrare di cosa si è capaci. Questo significa essere uomini? Quando non si riesce più a distinguere la condanna di un’azione sbagliata dalla persona che l’ha compiuta, la strada da imboccare non può non essere quella della vendetta, come se la persona sia la personificazione del male e per questo vada eliminata.
Così come Dio lo ha pensato, l’uomo è colui che incarna nella sua storia i tratti caratteristici del Padre. A meno di questo si danno solo acconti di umanità, non uomini e donne in pienezza.
“Come il Padre…”: ecco a cosa siamo chiamati. Essere “come il Padre”. La vita cristiana non è una sorta di navigazione a vista: esiste un modello di rotta ben preciso ed è il Padre.
A fronte di certi nostri metodi sbrigativi e dozzinali di risolvere il problema del male, la legge del taglione (un grande traguardo rispetto alla sproporzione della vendetta) è distante mille miglia: come si può arrivare a ripagare uno sguardo di troppo o una parola detta fuori luogo con spranghe e coltelli?
Una dilatazione del cuore che arrivi a spezzare la spirale di vendetta e di morte che fa capolino all’interno delle nostre relazioni: ecco l’obiettivo che si prefigge questa liturgia della Parola che marca una distanza abissale rispetto al nostro piccolo cabotaggio. È accaduto a tutti noi di essere vittime di un sopruso di fronte al quale, come per un istinto naturale, abbiamo avvertito una sorta di diritto alla vendetta così da restituire quello che a nostra volta avevamo ricevuto. La convinzione che soggiace all’esercizio di un tale diritto è quella di arrivare all’eliminazione dell’ingiustizia, mentre così non è. Non basta, infatti, distribuire equamente il male (a torto, torto) perché esso perda la sua forza. A vincerlo non è altro male, ma solo il bene.
Tuttavia, abbiamo bisogno di essere messi in guardia dal buonismo. Una lettura semplicistica di questo brano evangelico potrebbe favorire un cristianesimo sempre e comunque disposto a subire, una sorta di arrendevolezza che non ha nulla a che vedere con quello che Gesù intende proporre.
Il porgere l’altra guancia, infatti, non è un gesto remissivo ma invito rivolto all’altro perché si chieda da dove nasce la sua violenza e a che cosa può portare.
Il porgere l’altra guancia è scegliere un percorso umano che non passa attraverso la strada che l’altro ha intrapreso precedentemente usando violenza.
Questa è la sfida che ci sta davanti: un percorso di umanizzazione che arrivi a tenere distinte colpa e persona. Il ricambiare violenza con violenza equivale a incasellare l’altro in uno schema riduttivo secondo cui “tu sei la tua colpa; tu equivali a quello che hai compiuto”. Forse che il Padre fa questo con noi? Se così fosse quale speranza avremmo di ottenere misericordia.
L’amore per il nemico non è rassegnazione ma corrisponde all’esercizio tanto difficile quanto non scontato di non rinchiudere l’altro nell’immagine che egli mi ha mostrato: l’altro è molto di più del gesto malvagio che può aver compiuto. Nessuno è omologabile alla sua violenza come non lo è alla sua colpa.
Più avanti, proprio nel vangelo di Mt, Gesù ribadirà che il problema all’interno di un contenzioso non è tanto arrivare a stabilire chi abbia ragione e chi torto. L’obiettivo non è averla vinta: decisivo, infatti, sarà chiedersi come guadagnare un fratello, come ristabilire una relazione, come non perdere il rapporto con l’altro. A tema non c’è il danno (come accade nel nostro modo di amministrare la giustizia), ma la relazione.
Certo, si può obiettare, non tutti i conflitti si riescono a sanare. Pietro e Paolo, per diversità di vedute dovranno dividersi. Paolo dovrà addirittura prendere le distanze anche da altri discepoli. Non sempre i rapporti sono della serie: “e vissero felici e contenti”. È vero. Alcune relazioni restano sospese. Alcune situazioni non si ricomporranno facilmente qui sulla terra: in questo caso l’unico atteggiamento possibile è il non perpetuare la violenza reiterandola. Sarà necessario accettare che le strade si dividano con questa convinzione: scelgo di lasciarti vivere come tu scegli di lasciarmi vivere, stando a debita distanza. Perché questo accada è necessario assumere l’impegno di non ferirsi nuovamente.
C’è un silenzio – e il vangelo ce lo testimonia durante la passione di Gesù – che vorrebbe essere un ultimo tentativo perché l’altro prenda coscienza della sua situazione e scelga di intraprendere un nuovo percorso. Forse capiamo così anche perché Gesù, sulla croce, non dica: “Io vi perdono” ma “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Chi non è consapevole del male che può aver compiuto, con difficoltà è disposto ad accogliere parole di perdono. Gesù prega perché non è riuscito a far prendere coscienza di che cosa fosse veramente in gioco in quella vicenda.