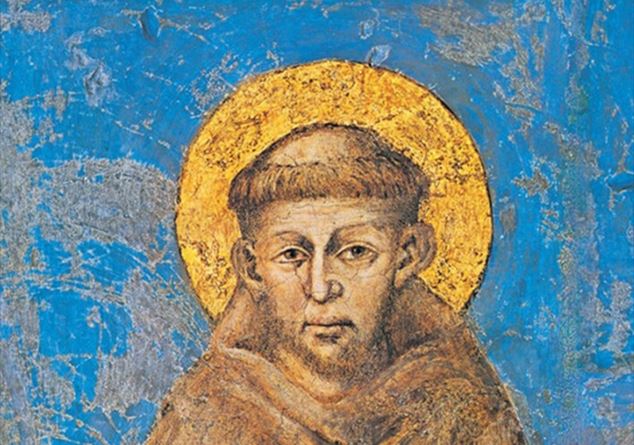"Questo ministero straordinario, quindi suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati… Il servizio dei ministri straordinari se preparato e continuato nel dialogo di amicizia e fraternità, diventa chiara testimonianza della delicata attenzione di Cristo che ha preso su …
“Questo ministero straordinario, quindi suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati… Il servizio dei ministri straordinari se preparato e continuato nel dialogo di amicizia e fraternità, diventa chiara testimonianza della delicata attenzione di Cristo che ha preso su di sé le nostre infermità e i nostri dolori”[1].
Ecco la prospettiva da cui intendo partire: la delicata attenzione di Cristo. Tutti coloro che esercitano un ministero nella Chiesa, è questo che sono chiamati ad esprimere e a far esperire.
Premessa
“Quelli della via”, così At 9,2 definisce i discepoli del Signore, uomini e donne in cammino, a dire che l’appartenenza a Lui non è qualcosa di codificato una volta per tutte, ma si invera di volta in volta proprio lungo il cammino.
Il cammino di un cristiano non è mai determinabile da sé: la strada non può che essere quella di Gesù il quale ha detto: “Se qualcuno vuol venire dietro a me… mi segua”. La via di Gesù ha sempre due caratteristiche:
- è un discendere fino a divenire simile agli uomini (cfr. Fil 2,5-11); (oggi, forse, questo rischia una deriva: fermarci all’umano tout court, un umano fine a se stesso, senza alcuno sbocco su un oltre, senza altro approdo se non il suo ben-essere),
- ed è un ascendere, un non restare impigliato nei lacci della morte. La Pasqua segna tutta l’esistenza cristiana eppure è ciò che i cristiani più faticano a comprendere.
I due di Emmaus sono in qualche modo il prototipo della fatica a comprendere la via di Gesù. La sera di Pasqua, infatti, il loro è il cammino della resa, della ritirata. La tristezza del loro sguardo lascia trasparire il vuoto e il peso del loro cuore. Proprio la loro vicenda è quella che parla di più per i tanti uomini e donne che battono sentieri non sacri, cammini non qualificati, soprattutto quando questi cammini finiscono per far leggere la propria storia come fallimentare, come una promessa non mantenuta, una speranza frustrata.
È verso quel percorso interrotto che si affrettano i passi di Gesù. Ora, la Chiesa esprime al massimo ciò per cui il Signore l’ha voluta quando, sulla scia del suo Signore, ha la forza di presidiare i crocicchi delle strade degli uomini, di raggiungere i sentieri interrotti. Il compito, però, è per nulla scontato: lontano da Gerusalemme, infatti, si incrociano tante strade e non tutte immediatamente riconoscibili come indirizzate a un approdo sicuro. I percorsi possono essere indirizzati se c’è disponibilità all’incontro e accoglienza di tutte le domande, come pure degli eventuali silenzi o delle manifeste ritrosie. Il più delle volte le domande non sono neppure espresse: una delle difficoltà dell’uomo contemporaneo è proprio l’incapacità di dare un nome al suo disagio.
Per usare un’immagine che a me piace molto, si tratta di una pagina consegnata a noi dalla Provvidenza di Dio “come istruzioni in caso di panico”[2] (G. ZANCHI, Rimessi in viaggio, Vita e pensiero, Milano 2018, p. 8).
Queste istruzioni oggi ci vengono consegnate perché ne sappiamo fare buon uso nel ministero che esprime un vero e proprio approssimarsi del Signore mediante le nostre persone.
Il metodo Emmaus
Quella sera, proprio perché quei due erano a rischio, Dio stesso si mise sulle loro tracce dando inizio a un vero e proprio metodo, il metodo Emmaus. È un metodo un po’ insolito e anche alquanto faticoso, tant’è che il più delle volte, nella nostra prassi ecclesiale, è sufficientemente bypassato.
Di cosa si tratta? Si tratta della disponibilità a camminare con qualcuno lasciandolo parlare: “Di cosa stavate discutendo lungo il cammino?”.
L’approccio non inizia con il rimprovero, non inizia neppure con l’annuncio e neanche con la morale. Il metodo Emmaus inizia con il mettersi al passo dell’altro suscitando domande. Dio solo sa quanto abbiamo bisogno della capacità di suscitare domande in un tempo in cui patiamo le risposte preconfezionate, soffriamo per i messaggi inviati in serie sopra i quali compare “inoltrato”. Chi te li invia non si è preso neppure la briga di personalizzarlo. Dio no: “anche i passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell’otre tuo raccogli” (Sal 56,9). Il nostro è il Dio che sa contare fino a uno. Uno che è abituato a contare i passi e a raccogliere le lacrime di ognuno, volete che si accontenti di qualcosa di generico e di generale?
Prima che dare una risposta Gesù esercita la maieutica dell’interrogativo, aiuta, cioè, a interrogare e a interrogarsi. Perché mai? Perché noi viviamo molteplici esperienze ma ci fermiamo alla superficie senza accettare di andare fino in fondo così da individuare come stare a contatto con esse e, semmai, scoprire quale contributo possiamo apportare perché abbiano un esito diverso.
A chi è assuefatto a ogni cosa, a cosa serve una lieta notizia? Non suscita alcun interesse. Ciò che gli manca, invece, è la capacità di cercare ancora, di desiderare, di interrogare, appunto.
“Tu solo sei così straniero?”.
E pensare che il termine è tradotto con paroikeo, da cui viene parroco. Accusano Gesù di essere estraneo ai fatti capitati pochi giorni prima. Accusandolo, in realtà, stanno affermando una cosa tanto vera: Gesù è estraneo a una cronaca colorata solo di nero. Perché la lettura delle cose possa cambiare, è necessario misurarsi con ciò che immediatamente ci risulta estraneo. E se lo straniero che si è affiancato a noi per scuotere la nostra fede che si affievolisce fosse proprio un evento non preventivato che ti chiede di non dare nulla per scontato ma di interrogare e di interrogarti? Dio ci visita sempre mediante la “stranierità”, qualcosa che immediatamente è fuori dalla mia presa.
Saranno in grado di riconoscere il segno del pane solo perché, lungo la via, hanno accettato di lasciarsi mettere sottosopra dalla domanda, prima, e dall’annuncio, poi. C’è voluto del tempo e della strada, 11 Km, prima di arrivare a quel segno. Non dimentichiamo la tentazione del vitello d’oro. A fronte di un Mosè che se n’è rimasto per 40 giorni sul monte solo con Dio, c’è sempre un Aronne di turno pronto a fabbricare qualcosa di tangibile. Trovo che sia una tentazione ricorrente.
I momento: la memoria perduta (Arteriosclerosi)
Noi speravamo…
I due di Emmaus – come noi del resto – vivono una esperienza di memoria perduta. Non è, talvolta, la stessa esperienza di chi è provato dalla malattia o dalla solitudine, dalla vecchiaia o da qualcosa che ha scombussolato l’assetto ordinario delle cose? E una simile esperienza non risparmia nessuno, neanche i consacrati. E così ci si ritrova a discutere come i due di Emmaus di tutte le cose che ci sono accadute ma senza saperle leggere.
Hanno innumerevoli informazioni ma sono privi del codice interpretativo. Manca loro la chiave di lettura che solo Gesù darà loro. Gesù non negherà i fatti ma dirà proprio a loro: “ma non sapevate che bisognava che il Cristo sopportasse tutte queste sofferenze per entrare nella sua gloria?”.
La chiave di lettura la troveranno solo dopo un lungo ascolto e un segno rapido.
Essi si sono fermati alla superficie e le informazioni dolorose li stanno schiacciando. Sono gli uomini del kronos, vocabolo greco che indica il tempo come contenitore. È il tempo visto nel suo accadere esterno. Un tempo come susseguirsi di cose senza cogliere l’avvenimento che quelle cose racchiudono.
Accadimento e avvenimento
Durante le esequie di una donna morta suicida proprio dietro la casa canonica della mia parrocchia dissi così:
“Questo evento chiede a noi di discernere quale parola è custodita in esso per ciascuno di noi. Ci chiede di far sì che quello che ad una prima lettura cogliamo come un accadimento, una cosa che ac-cade senza alcun senso perché letteralmente ci è piombato addosso, diventi un avvenimento: anche in questa esperienza di dolore c’è un cammino di Dio verso di noi. Ecco perché non stiamo facendo una commemorazione ma salutiamo la nostra sorella con spirito di fede”.
I due di Emmaus sono incapaci di una lettura simbolica. Ora, non c’è vita cristiana senza lettura simbolica: o tutto per me è presenza e rinvio al mistero di Gesù Cristo o non è possibile una vita evangelica. Se non è riferimento al mistero, la mia esistenza sarà necessariamente una esistenza di calcoli, di rivalse, di profitti personali, ma non di adesione totale alla persona che mi ha afferrato.
A questi uomini immersi nel kronos manca la consolazione del kairòs, ossia il tempo come occasione della visita di Dio, tempo della salvezza, il tempo come luogo teologico: è il tempo in cui accadono eventi non semplici cose.
Noi possiamo vivere le nostre giornate facendo una cronaca esatta ma senza scendere in profondità, senza cogliere l’appuntamento che il Signore ha fissato per noi. Tutti noi, oggi più di ieri, attraverso la nostra cultura massmediale, siamo immersi nella cronaca. C’è una cronaca che prova continuamente a buttarmi in una lettura simbolica della realtà. Si tratta di eventi che non possono non buttarci nel mistero della morte e della vita, nel mistero della nostra fragilità umana, ma subito dopo i mass media mi danno un’altra cronaca, di tutt’altro tipo, e una cronaca cancella l’altra e non ci è consentito di cogliere l’avvenimento.
I due di Emmaus ci rileggono. Manca a loro e a noi la consolazione del kairòs: Dio mi sta visitando. Anche in un tempo di malattia o, comunque, di desolazione.
Che cos’è, perciò, la vita spirituale? Vivere il kronos come kairòs. Non possiamo sottrarci al kronos: è accaduto un incidente d’auto, c’è una persona malata, un malato terminale, una famiglia con un dissesto economico. Questo è il kronos, ma il discepolo lo vive come un kairòs perché non è che io incontri la visita di Dio fuori dal fatto ma è nel fatto che io leggo la visita di Dio.
Comprendiamo così che essere uomini della memoria significa riconoscere che non esistono cose banali, tutto ha spessore. Per un cristiano la lettura del reale non ha mai una valenza solo fenomenica di tipo sociale, economico, culturale: essa è sempre chiamata ad essere teologale.
I loro occhi erano impediti…
Non riuscivano a leggere in profondità. Esiste nel mondo un arcipelago di luce che a volte noi non siamo in grado di riconoscere perché ci manca lo sguardo. Sovente i nostri sguardi sono impediti: oculi eorum tenebantur. Forte questa parola di Luca. Può accadere che eventi di grazia siano ridotti soltanto a immagini massmediali.
Ecco la prima nota, il primo momento del nostro accostarci alle persone che visitiamo: uomini e donne dalla memoria perduta.
La vita spirituale è proprio la capacità di trasformare la cronaca in evento. Di sola cronaca, infatti, si può morire.
Noi speravamo…
Il loro è un vangelo senza Pasqua. Non è un vangelo senza la Pasqua anche tanta nostra vita “religiosa”, allorquando la speranza cede il passo alla disillusione?
Certo, il disinteresse non è totale: i due di Emmaus enunciano anche dei segni che avrebbero postulato un approfondimento ma poi avevano ripiegato al dato di realtà: “ma lui non l’hanno visto”.
I due hanno bisogno di incrociare qualcuno che li aiuti a narrare, a dirsi, a non cogliere la loro esistenza come un insieme di frammenti, aprendosi alla consapevolezza che il senso di ciò che essi colgono come a spezzoni, è tenuto insieme dall’amore stesso di Dio.
Perché ciò accada è necessaria una Chiesa che si faccia compagna di viaggio proprio come Gesù: ecco il senso del vostro ministero. È la presenza di Gesù e il suo interessarsi a far sì che le domande inizino a trovare un percorso logico. Oggi più che in passato, il mandato vocazionale della Chiesa è quello di far sì che i tratti scomposti del volto di ognuno siano reintegrati in una immagine coerente che permetta di far affiorare l’interrogativo di fondo, quello che non fa compiere il passo della fede e non fa scaturire una dedizione al Signore e al suo regno.
II momento: la memoria ritrovata
La vicenda dei due di Emmaus (la vicenda di tanti nostri fratelli e sorelle, la nostra stessa vicenda, talvolta), ci ricorda come non basti aver avuto familiarità con Gesù.
Non c’è battesimo, né ordine sacro, né consacrazione che ci eviti di attraversare i giorni bui in cui l’unica luce che ci attira è quella fosca che sa di morte e perdizione. Non c’è neppure età e lunga frequentazione di chiese che ci confermi in grazia, nel bello e nel vero, nella vita e nell’amore.
Non era la prima volta che lo ascoltavano ma non lo avevano mai visto con gli occhi della fede ed egli glielo fa notare: “Sciocchi e tardi di cuore nel credere!”. Tanti dei nostri fratelli (noi stessi, talvolta) hanno una frequentazione con Gesù che si ferma sulla soglia della fede senza, però, oltrepassarla.
Il passaggio dalla consuetudine alla fede, quella sera e ogni sera della nostra vita, accade solo grazie alla Parola. Solo il riferimento al mistero della persona di Cristo permette di gettare luce su tutto: sulla passione, sulla morte, sul sepolcro, sulle apparizioni degli angeli. Se l’itinerario di un uomo non diventa un itinerario con Cristo, la sua storia arriva sempre ad un punto di non ritorno.
“In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo… Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione”[3].
Questo ci ricorda il Concilio e questo è anche il tema del nostro anno pastorale.
Privi di intelligenza e tardi di cuore…
Una diagnosi spietata e drammatica, immediatamente, ma vera. Un medico che non ci dicesse la verità, non farebbe al nostro caso. Ecco il nome dei due di Emmaus, ecco, talvolta, il nostro nome.
Privi di intelligenza…
Intelligenza viene dal latino intus-legere, leggere dentro. I loro occhi erano impediti e non leggevano dentro. Il discepolo è uno che legge dentro, che va oltre le apparenze, scende in profondità. L’intelligenza chiusa e bloccata e la durezza di cuore vanno di pari passo. E, di solito, tutto questo ben si sposa con la chiacchiera: era proprio quello che stavano facendo.
Con le sue parole Gesù entra in questa chiusura di mente e in questa aridità di cuore. Egli non si preoccupa di questa mancanza di intelligenza spirituale e di questa durezza di cuore. La affronta e la penetra: questo vuol dire che anch’io sono chiamato a fare così con me e con i fratelli. La Parola di Dio fronteggia questa mia realtà così umana e la penetra in profondità. Non abbiamo paura di lasciarci raggiungere.
Spiegò loro…
La Parola illumina l’intelletto, ci consente di leggere dentro e riscalda il cuore. È ciò che fa in noi la lectio divina.
Non pensiamo di dover prima metterci in ordine e poi ascoltare la Parola di Dio. Se facciamo così la Parola ci scivola addosso, raggiunge i comportamenti ma non scende in profondità (cfr. evangelizzazione dei comportamenti/evangelizzazione del profondo). È indispensabile, invece, che entri dentro, per evangelizzare le nostre profondità: ecco quello che Gesù fa nei loro confronti. Fronteggia quella loro situazione, la assume, la attraversa e la illumina, tanto è vero che è proprio ciò che ricorderanno di lì a poco come sensazione provata: “non ardeva forse il nostro cuore…?”. Sarà la cosa che più ricorderanno: come si erano sentiti. È quello che accade in tanti nostri incontri: non tanto le cose dette ma l’essere stati riconosciuti e accolti.
Il punto nodale per ritrovare la memoria è quello che Gesù dirà: “non doveva forse il Cristo patire tutto questo per entrare nella sua gloria?”. Era previsto che fosse così. La cifra è la Pasqua: il Cristo doveva patire ed entrare nella sua gloria. La Pasqua non risparmia nessuno e non una sola volta.
I due riconoscono che quello sconosciuto che si affianca ai loro passi è uno sconosciuto saggio, è più informato di loro: essi sanno le stesse cose ma quello sa interpretarle.
Resta con noi…
I due non hanno detto: Resta con noi, Signore. L’aggiunta, infatti, è nostra. Non stanno invocando la presenza del Signore. La loro non è una richiesta di aiuto ma un gesto di spontanea accoglienza. Offrono a quello sconosciuto una fraternità che aiuti a vincere la solitudine e l’estraneità della notte. Quello sconosciuto, per loro, è un povero a cui offrire un gesto di attenzione.
Questo è il primo frutto dell’ascolto della Parola: far ardere il cuore così da aprirlo all’accoglienza. La Parola ascoltata suscita e genera disponibilità. Proprio la Parola li sta trasformando. Erano partiti tristi, ma l’accoglienza della verità sulla loro vita si traduce in accoglienza verso i fratelli. La parola di Dio, infatti, dona la fede e la fede genera la carità. L’apertura alla carità di una circostanza può far sì che scaturisca l’interrogativo su come renderla una forma stabile di vita.
L’invito dei due di Emmaus è accolto dallo sconosciuto viandante e quando si ritrovano a tavola, il volto di quel povero si trasfigura fino a delineare i tratti stessi del Signore di cui riconoscono parole e gesti. Quell’uomo non è soltanto un viandante sconosciuto tanto saggio, non è neppure soltanto un povero a cui dare ospitalità ma il Signore stesso. Solo adesso i loro occhi si aprono.
“La storia è il modo con cui Gesù ci parla e si accosta a noi. Senza che noi possiamo riconoscerlo. Arriva con passo felpato, anonimo, apparentemente indecifrabile… Molti credenti sarebbero tentati di disfarsi al più presto di questa interferenza della storia, di questo ‘estraneo’ che vuol mettere il naso nelle loro cose, profanando il loro lutto. Molti altri invece decidono di fidarsi. Capiscono che bisogna restare in compagnia dello straniero… Bisogna restare fraterni commensali del presente, del proprio tempo, dell’umanità di oggi, perché quello è il volto che Gesù sceglie ogni volta per rivolgersi alla nostra stanca inquietudine…
Questo tempo che infrange i nostri sogni è capace anche di aprire i nostri occhi. Il Signore ci ha sempre parlato cosi. Non è scomparso”[4].
La tentazione di cancellare il mistero pasquale
La tentazione grande della Chiesa è davvero quella di cancellare la Pasqua. La grande tentazione nella nostra vita è il voler cancellare il dolore perché nel dolore non vediamo l’appuntamento di Dio, perché il dolore da solo è invivibile. Gesù Cristo ci rivela un Dio che non è amico del dolore, Gesù combatte il dolore, ma questo resta pur sempre un luogo di passaggio e di rivelazione. Nel dolore illuminato scopriamo la gloria (il Risorto è il Crocifisso), eppure saremmo portati a cancellarlo: i segni del dolore rimangono, sono rivisitati alla luce della Pasqua. Trasformare il dolore in gloria: ecco il nostro compito. Si tratta di una esperienza che non si improvvisa: accade per grazia. Chi incontra il Signore nella sua vita riesce a restituire un senso anche a ciò che immediatamente sarebbe solo assurdo.
Quanto più la Chiesa diventa Chiesa dell’efficienza, dei programmi, delle strategie, della visibilità, dei likes, diventa Chiesa del potere e la Chiesa del potere è una Chiesa che cancella la Pasqua.
Fare memoria significa allora tornare sempre al centro e il centro è la Pasqua.
III momento: la memoria ritrovata si fa racconto
Davanti al Signore che spezza se stesso comprendono che solo attraverso l’umiliazione e l’abbassamento fino al dono totale di sé, si raggiunge la vita piena. Tuttavia, il mistero contemplato non è il termine del loro viaggio: Emmaus è solo una sosta, necessaria senz’altro, ma sosta, non dimora. Anche il vostro/nostro ministero è solo un’occasione, non l’approdo.
Il Cristo totale vive altrove, a Gerusalemme, dove è riunita la comunità e dove, infatti, si dirigono i passi dei due. Non siamo dei battitori liberi che stazionano nella locanda di Emmaus, siamo credenti che ritrovano la loro identità intorno agli Undici. Quando tornano, infatti, non ci sono domande ma l’offerta della testimonianza che convalida la fede di tutti: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. È la fede dell’apostolo la garanzia per la nostra fede.
Il disegno di Dio su di noi è radicato nella comunione ecclesiale ed è proiettato verso l’annuncio del vangelo.
Chi è capace di compiere il percorso di Emmaus vede la tristezza tramutarsi in gioia, la preoccupazione di sé aprirsi al dono, il Signore non è più perduto, si sperimenta una comunione che mette le ali ai piedi e la tenebra della sera cede il posto alla luce della risurrezione.
I due di Emmaus pur discutendo, dibattendo e interrogandosi tra di loro in fondo facevano un discorso che si fermava alla superficie, ai fatti. Ora la memoria li rende narratori di avvenimenti e annunciatori. Quando noi non abbiamo una memoria profonda non abbiamo nulla da dire: oggi nella Chiesa abbiamo uomini e donne di grande memoria?
Penso alla superficialità con cui tante volte accompagniamo, ad esempio, le persone nel loro trapasso o come celebriamo le esequie (es. funerale del ragazzo suicida) o come accompagniamo la crisi di una coppia. Quello è il momento in cui siamo chiamati ad essere gli uomini della memoria e non solo dei ripetitori automatici che non si lasciano interpellare da ciò che accade.
Forse abbondiamo di pubblicitari, di slogan ma siamo carenti di mistagoghi. Qual è il confine tra l’essere pubblicitari e l’essere mistagoghi? È la solidità della memoria cristiana.
Oggi i cristiani fanno fatica ad essere uomini della grande memoria perché presi dalla legge del mercato, dal non voler perdere le posizioni e ci manca non il tempo ma la capacità interiore di essere uomini della memoria. Acutis, Frassati, Bartolo Longo, uomini della grande memoria.
È soltanto la memoria profonda che ci rende narratori di eventi e annunciatori. Perché non funziona la nostra evangelizzazione? Perché parliamo di cose che talvolta non ci hanno mai sfiorato: ripetiamo delle formule, non il racconto di ciò che dà luce alla nostra esistenza, anzitutto.
Noi abbiamo bisogno di uomini e donne della grande memoria, che ci aiutino a leggere ogni cosa dal punto di vista di Dio.
La fractio panis che seguirà, sarà un attimo. È come se Gesù in questa pagina non abbia tanto la premura di portarli a messa quanto di evangelizzarli. L’Eucaristia è un attimo. Certo c’è l’adorazione eucaristica, ma senza evangelizzazione l’Eucaristia diventa magia, diventa idolatria. Quante volte l’Eucaristia è presentata come un oggetto sacro e non il segno povero che ci dice una presenza reale del Risorto. E se non sono evangelizzato, di fronte all’Eucaristia divento uno che sbaglia obiettivo.
Il verbo narrarono, viene da exegounto, che non vuol dire soltanto fare esegesi. È lo stesso verbo usato da Gv nel prologo: exegesato, il Figlio è l’esegesi del Padre non nel senso di una lettura comprensiva, intellettuale, ma è la narrazione della sua esperienza del Padre. I due, narrando, comunicano una esperienza che è proprio quello che siamo chiamati a fare noi.
Noi tutti ci accorgiamo se le parole di uno che ci parla sono vere o se il suono delle parole è un suono falso perché narra come da repertorio, racconta quello che ha studiato. I due di Emmaus sono due che han fatto memoria e quindi possono dire quello che hanno dentro.
In loro, il germogliare della speranza va di pari passo col ritrovamento della memoria. E così si ritrovano a passare dal desolato “Noi speravamo” ad un atteggiamento nuovo: ascoltano uno sconosciuto tanto da chiedergli di fermarsi presso di loro.
Gli occhi che prima erano impediti, ora si aprono: “si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”. In più, riescono a dare un nome a quello che sentivano dentro di sé mentre lo ascoltavano.
Tutto questo permette loro qualcosa che fino a qualche istante prima sarebbe stato impensabile: “si alzarono, tornarono a Gerusalemme, trovarono riuniti, raccontarono”. Compiono di notte quel viaggio per cui avevano dissuaso lo sconosciuto.
Ed io? Sono uomo della narrazione perché sono uomo della memoria sempre viva?
[1] CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Benedizionale, Roma 1992, n. 2004, 1-2.
[2] G. ZANCHI, Rimessi in viaggio, Vita e pensiero, Milano 2018, p. 8
[3] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et spes, n.22
[4] G. ZANCHI, Rimessi in viaggio, Vita e pensiero, Milano 2018, pp. 13-14