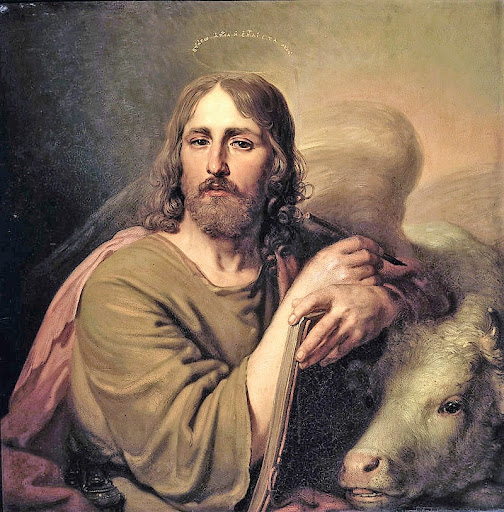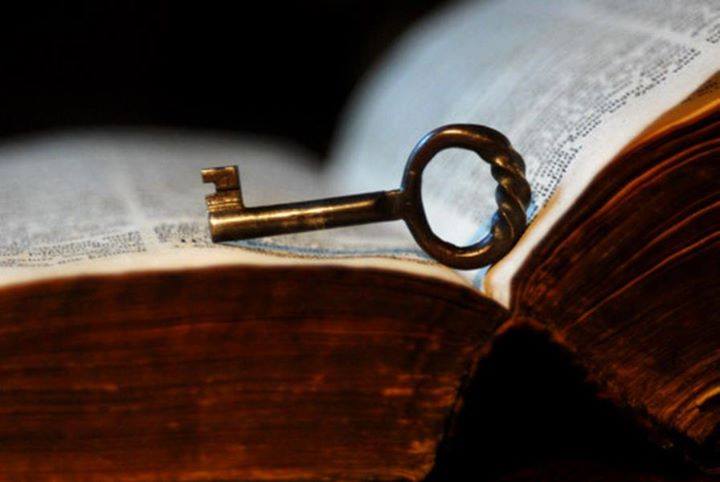Un vero e proprio pellegrinaggio nella geografia dello Spirito quello che la liturgia della Parola di questa messa nella vigilia dei Ss. Pietro e Paolo ci propone: il tempio, la strada di Damasco, il mare di Tiberiade. Tre luoghi diversi e distanti l’uno dall’altro, nei quali si compie l’opera di Dio e viene dischiusa una …
Un vero e proprio pellegrinaggio nella geografia dello Spirito quello che la liturgia della Parola di questa messa nella vigilia dei Ss. Pietro e Paolo ci propone: il tempio, la strada di Damasco, il mare di Tiberiade. Tre luoghi diversi e distanti l’uno dall’altro, nei quali si compie l’opera di Dio e viene dischiusa una precisa immagine di Chiesa.
Tutta da apprendere da parte nostra la geografia di Dio, convinti come siamo che solo alcuni siano i luoghi “di” Dio o le esperienze per “dire” Dio. Quanto avremmo bisogno di apprendere da Francesco d’Assisi quell’arte che immediatamente sa di ingenuità e che invece è altamente sapienziale, un’arte che lo portava a raccogliere tutte le scritte che trovava in giro perché – diceva – con ogni lettera è possibile riscrivere il nome di Dio! Ogni lettera, ogni aspetto di noi, ogni ambito della nostra vita, persino ogni brandello.
- Il tempio, anzitutto.
Nei pressi del tempio c’è un uomo – figura di tutti noi – impossibilitato ad entrarvi e di fronte a lui Pietro che gli dona l’opportunità di riprendere il cammino. L’immagine di un Pietro figura di un preciso volto di Chiesa che non ha né argento né oro. Espressione che ci dà la giusta misura dell’avventura di Pietro e di Paolo e con loro dell’intera comunità cristiana consapevole di possedere solo Gesù Cristo, non già come un patrimonio su cui avanzare diritti di esclusiva ma come dono da condividere con ogni uomo sulla terra. Gesù Cristo è l’essenziale per Pietro, per Paolo, per la comunità dei discepoli. Gesù Cristo, non una dottrina o una serie di nozioni ma – come attesta la stessa etimologia del nome – l’essere introdotti nell’esperienza di Dio che salva.
Si configura così l’unica ricchezza di cui dispone la comunità dei discepoli: compiere l’opera stessa di Gesù di Nazaret il quale – attestano gli Atti – passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Nessun potere umano ma quello di restituire speranza.
Ecco quando possiamo rivendicare la prerogativa di essere discepoli: solo quando avvertiamo come urgente il compito e la passione di introdurre l’altro, chiunque esso sia, in una esperienza di vita nuova.
Il gesto di Pietro nei confronti dello storpio è immagine dell’azione di una Chiesa che si approssima – si fa prossimo – a una umanità ferita, nei confronti della quale prolunga i gesti del suo Signore, mettendola nella condizione di camminare con le proprie gambe e offrendole la possibilità di entrare in comunione piena con Dio. Il paralitico guarito, infatti, scopre un accesso finora precluso: entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio (At 3,8). Pietro è immagine di una Chiesa contenta della compagnia degli uomini. Quell’uomo escluso è ammesso nella compagnia di Pietro e Giovanni: con loro.
- Poi la strada di Damasco.
Sulla strada di Damasco viene delineata da Paolo, invece, un’altra immagine di Chiesa. Paolo era ancorato a un modo di intendere il rapporto con Dio come qualcosa da meritare, da conquistare. Sulla via di Damasco, invece, si dischiude un nuovo modo di concepire la vita e la fede, un vangelo, appunto e per grazia si diventata partecipi di ciò di cui Dio ci fa dono. Testimoni di una misericordia che a nostra volta abbiamo ricevuto e di cui siamo costituiti debitori nei confronti dell’umanità. Una Chiesa consapevole del dono ricevuto: ben a ragione è stato affermato che Dio non si merita ma lo si accoglie così come a lui è piaciuto manifestarsi a noi.
- Poi il lago di Tiberiade.
Qui è a tema la fiducia restituita. A Pietro che per tre volte ha rinnegato il suo Signore e Maestro affermando solennemente – non lo conosco! – per tre volte viene chiesto di esprimere il suo amore per Gesù. E Gesù lo fa anzitutto puntando alto: mi ami tu più di costoro? Del resto era stato lo stesso Pietro a proclamare un amore simile ancora tutto da passare alla prova degli eventi: anche se tutti ti abbandonassero io… E tuttavia, ora che i fatti registrano tutt’altro esito rispetto alla proclamazione, Pietro assume una misura umile: ti voglio bene. E così per due volte. La terza, è Gesù stesso ad assumere la misura di Pietro: mi vuoi bene? Tu sai tutto, risponde Pietro, tu sai… Un Dio che per farmi diventare ciò che sono chiamato ad essere, mi prende per quello che sono, comincia dalla mia fragile misura.
Un amore che questa volta avrà la sua cartina di tornasole non nella dichiarazione di un affetto generico e vago ma nel prendersi cura di coloro che il Signore gli affida: i più piccoli. Se è vero che mi vuoi bene, prenditi cura dei miei piccoli. A Pietro non è consegnato un privilegio o un potere come un giorno forse avrebbe desiderato quando immaginava un Messia potente, ma il compito di mettersi a servizio dei fratelli fino ad entrare in una disponibilità finora impensata.
- Nazaret
C’è poi un altro luogo indicato dalla ricorrenza alla quale ci stiamo preparando: Nazaret. Mi ha sempre colpito il fatto che Dio abbia scelto di entrare nella storia proprio per la porta secondaria, non attraverso l’ingresso principale. Nazareth è quasi una parentesi o una distrazione della storia e della geografia delle Scritture, fuori dalle rotte sacre e profane. Eppure qui il Cielo ha deciso di posare il suo sguardo e la sua mano invisibile.
Cos’era Nazareth ai tempi di Maria, rispetto a Gerusalemme, se non uno sperduto villaggio della Galilea? Cos’era una casa rispetto a un tempio? Cos’ era una donna rispetto a un uomo?
Il giorno in cui gli Filippo dirà a Natanaele di aver trovato il Messia da Nazareth, questi non tarderà a fare spallucce: “Da Nazareth? Cosa può mai venir di buono da Nazareth?” (cfr. Gv 1,46).
Eppure Nazareth è la vita stessa di Gesù, la parte più cospicua in cui, per lunghissimi anni, il Figlio stesso ha imparato ciò che sta a cuore al Padre (“non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” Lc 2,49) proprio attraverso l’assunzione e la condivisione dell’ordinario. A Nazareth, alla scuola di Maria e Giuseppe, il Figlio ha appreso la valenza dell’insignificanza e il significato dell’irrilevanza. Nazareth rappresenta la forza e l’eloquenza della debolezza.
Penso alla mia, alla nostra Nazareth. Lì Dio mi passa accanto in un giorno qualunque, in una esperienza che nulla sembra avere di idoneo alla rivelazione di Dio.
Nessuno dei nostri luoghi e nessuna delle nostre esperienze sono inadeguate a che Dio si manifesti. Forse lo sta già facendo e io non me ne accorgo.